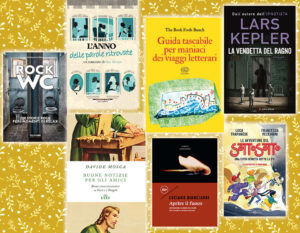Aprile 1978: sono passati tre anni da quando un misterioso virus ha decimato uno dopo l’altro tutti gli adulti di Berlino. In una città spettrale e decadente, gli unici superstiti sono i ragazzi e le ragazze divisi in gruppi rivali, che ogni giorno lottano per sopravvivere con un’unica certezza: dopo i 16 anni, quando meno se lo aspettano, il virus ucciderà anche loro. Tutto cambia quando qualcuno rapisce il piccolo Theo e lo porta via dall’isola dove viveva con Christa e le ragazze dell’Havel. Per salvare il bambino, Christa ha bisogno dell’aiuto di Jakob e dei suoi compagni. Si sviluppa intorno a questa traccia Berlin, I fuochi di Tegel, il libro di Fabio Geda e Marco Magnone. Ne parliamo con gli autori.
Berlin non è solo un libro, è un progetto ambizioso e articolato. Ce lo raccontate?
Berlin è anzitutto una saga per ragazzi: sette libri che usciranno uno ogni sei mesi. Ognuno sarà autoconclusivo per le singole vicende su cui si concentra ma legato a quello successivo da un cliffhanger per lo sviluppo della trama generale. Ma Berlin è anche un sito web, che darà l’opportunità ai lettori che avranno voglia di continuare l’immersione di leggere nuovi contenuti, di giocare con la storia e con i personaggi e anche di aiutarci a creare il mondo di Berlin, per esempio stimolando la scrittura delle fan-fiction. Abbiamo già pubblicato un giornale fake del 1975 mescolando notizie vere di cronaca dell’epoca, a notizie legate alla storia e ai personaggi di Berlin. Stiamo pubblicando i diari di alcuni protagonisti e a breve completeremo la mappa interattiva con cui approfondire la storia della città. E poi ci sono i laboratori nelle scuole che ci permetteranno di parlare sia del piacere della lettura sia di temi etici per noi rilevanti. Insomma: i limiti di Berlin li deciderà solo la nostra fantasia.
Fabio, ci sono tematiche comuni ai tuoi libri precedenti in Berlin?
Moltissime. La riflessione sul crescere, sull’educare, sul rapporto tra le generazioni (genitori-figli, adulti-ragazzi, maestri-alunni): tutti temi che in un modo o in un altro attraversano i miei romanzi e che risuonano forti anche in Berlin. A questi aggiungerei una certa idea di mondo e di confine, la necessità di superare i propri limiti e una tensione etica e morale focalizzata soprattutto su domande come: Quale società vorrei? A cosa serve la comunità? Ecco. A dirla tutta, pur rivolgendomi per la prima volta direttamente a un pubblico di ragazzi, pur essendo coinvolto per la prima volta in una narrazione seriale, sento Berlin come un gesto in forte continuità con i miei libri precedenti.
Marco, come mai la scelta di Berlino come ambientazione della storia?
Per diversi motivi. Anzitutto perché abbiamo immaginato un mondo senza adulti e la madre di questo archetipo è Il signore delle mosche di William Golding, che è ambientato su un’isola deserta in mezzo all’oceano. A noi piaceva l’idea di trasformare quell’isola naturale in un’isola urbana e Berlino Ovest tra il 1961 e il 1989 è stata esattamente questo: un’isola urbana nell’oceano della Repubblica Democratica Tedesca. E poi per la carica simbolica della città, che si divora e rinasce dalle proprie ceneri cambiando ogni volta pelle: Berlino nel corso del Novecento è stata la metropoli della modernità e delle avanguardie artistiche, la capitale del Terzo Reich e la città del Muro. Negli anni Settanta – quando è ambientata la nostra vicenda – è diventata la culla della scena alternativa e qui si sono incrociati il punk e la Guerra Fredda, la controcultura e Lou Reed, Christiane F. e David Bowie, la techno e l’incubo della Terza Guerra Mondiale. Secondo noi tutto questo l’ha resa la Gotham City europea, perfetta per l’immaginario post-apocalittico che cercavamo e per confrontarci con la Storia e le sue eredità.
Com’è stato integrare le idee e quindi scrivere a quattro mani?
Fin da quando abbiamo iniziato a parlare di Berlin ci è stato chiaro come per le mani non avessimo solo una storia da far progredire un libro dopo l’altro, ma un progetto molto più complesso, un mondo in cui immergerci grazie anche alle potenzialità del web. C’erano le ricerche storiche necessarie per un’epoca molto connotata, le trame da immaginare, i libri e i contenuti per la rete da scrivere. Nel tempo si sono aggiunti i social (Facebook, Twitter, Instagram), con cui ogni giorno ci confrontiamo direttamente con i nostri lettori, e i laboratori nelle scuole. Insomma, siamo in due perché abbiamo davvero tantissimo lavoro da fare. E lo facciamo come una band: ragioniamo insieme su ogni singolo aspetto del progetto, dalla trama generale a quella dei singoli libri, dallo sviluppo dei personaggi a cosa condividere in rete. Poi però sul piano della scrittura ci siamo divisi i compiti in modo netto: Fabio scrive i libri, Marco i testi per il web. Poi ciascuno di noi legge ed edita ogni singola riga scritta dall’altro. Cerchiamo sempre di arrivare a un punto di vista condiviso, ma quando si tratta di lingua, di poetica, be’, crediamo ci debba sempre essere uno sguardo prevalente da cui partire. Ma soprattutto come una vera band ci stimoliamo a vicenda continuamente, e ci divertiamo un sacco!
Vi siete chiesti perché i ragazzi dovrebbero essere curiosi di leggere Berlin?
Non solo ce lo siamo chiesti, ma è stata la domanda ricorrente per tutti e tre gli anni di gestazione della saga. E in tutta sincerità la risposta è quella che ci ha dato un giovanissimo lettore pochi giorni fa: Sto leggendo Berlin e mi sta piacendo un casino! Punto. La prima cosa che ci interessa è che piaccia un casino. Si legge per diversi motivi: per fuggire da una realtà verso cui si prova disagio, per lottare corpo a corpo con il mondo, per comprendersi, per vivere vite che altrimenti ci sarebbero negate e per tanti altri motivi, tutti nobili, tra cui: imparare. Ma questo, quando si parla con i ragazzi, è meglio non dirlo. Meglio evitare frasi come: leggi perché è importante, leggi perché impari. Non conosciamo un solo lettore giovanissimo che legga per questo motivo. Non conosciamo un solo lettore adulto che da bambino si sia appassionato alla lettura per questo motivo. S’inizia a leggere, da piccoli, perché leggere è dannatamente figo, emozionante in mille modi diversi. Poi, visto che idee e informazioni emotivamente cariche sono più facili da apprendere, finisce che dalla lettura si emerge avendo davvero imparato qualcosa: dettagli tecnici, contesti geopolitici, usi e costumi di culture altre – o a conoscere meglio se stessi. “Il mondo senza adulti”, d’altra parte, è un archetipo molto usato. A noi interessa riflettere su cosa può succedere nel momento in cui vengono meno le regole che reggevano una società e immaginare su quali basi può essere costruito un nuovo modello di comunità. Però una situazione del genere ci permette anche di raccontare i conflitti tipici dell’adolescenza e la pre-adolescenza: tra i nostri protagonisti c’è chi dovrà affrontare la maternità, chi la paura della morte, chi la scoperta dell’amore, chi il tradimento dell’amicizia.
Cinzia Cinque