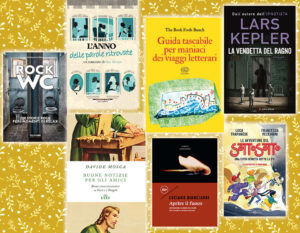Rachel è una bambina che vive in un orfanotrofio ebraico della New York degli anni Venti. Rachel è anche una donna, un’infermiera, che cerca di fuggire da un passato che l’ha fatta soffrire. Ma un giorno in ospedale arriva una paziente diversa, Mildred Solomon, che avrà un ruolo chiave proprio in quel passato che lei vorrebbe lasciarsi alle spalle… Narrato su due piani temporali, La bambina numero otto di Kim van Alkemade (Bookme – DeAgostini, 384 pagine, 16,90 €) si basa su fatti veri e su vicende realmente accadute e legate alla storia dell’autrice (nella foto) come ci racconta lei stessa in questa intervista.
La bambina numero otto non è solo fiction, ma è ispirato a fatti veri accaduti a New York. Quali?
«Il fatto che alcuni bambini, 8 per la precisione, nell’anno 1919, abbiano ricevuto cicli di “trattamenti” a raggi X da una dottoressa impiegata alla Hebrew Infant Home corrisponde al vero. Il suo nome nella realtà era Elsie Fox ed è stata lei a ispirare il personaggio di Mildred Solomon. Negli stessi anni e presso la stessa istituzione, il dottor Alfred Hess ha effettivamente condotto ricerche sul rachitismo, lo scorbuto e altre patologie. All’epoca, era molto frequente che i medici impiegassero cavie umane dagli orfanotrofi nell’ambito della sperimentazione e della ricerca. Le malattie infettive mietevano moltissime vittime tra i bambini e trovare nuove cure e vaccini era una necessità pressante. Tuttavia, capitava che membri della comunità medico-scientifica inducessero volontariamente l’insorgere di determinate malattie per poi studiarne gli effetti e le relative cure. Queste pratiche, benché criticate negli ambienti più illuminati, erano decisamente diffuse. Molti dei luoghi del romanzo corrispondono a posti reali. Nel descrivere l’orfanotrofio dove crescono Rachel e Sam, per esempio, mi sono ispirata allo Hebrew Orphan Asylum, che fu costruito negli anni Ottanta dell’Ottocento e chiuso definitivamente negli anni Quaranta del secolo scorso».
Quanto è stato duro per Rachel trovare se stessa e smettere di essere la numero otto?
«Trovare se stessa in quanto individuo è un processo che per Rachel dura tutta la vita. Incontrare la dottoressa Solomon e scoprire la verità sul proprio passato le consente di integrare le ingiustizie subite nella persona che è diventata: finalmente è nella posizione di compiere delle scelte, può decidere come reagire alle informazioni e alla consapevolezza che ha conquistato – e che trattamento riservare alla dottoressa Solomon. Essere l’orfana numero 8 significava non avere alcun potere di scelta, obbedire alle regole e essere una fra tanti. Diventare se stessa le consente di decidere quali regole seguire, di distinguere tra quelle giuste e quelle inique e comportarsi di conseguenza».
È più difficile vendicarsi o perdonare?
«Ciò che più mi interessava nell’esplorare la storia di Rachel è quanto attraente possa risultare la vendetta, quanto possa apparirci giusto restituire il dolore a coloro che ce lo hanno procurato.
Ma ferire qualcuno non porta pace a una persona che ha sofferto. La giustizia, naturalmente, è tutt’altro paio di maniche: la società ha il dovere di punire chi commette un crimine o procura sofferenza a un altro essere umano. Il perdono è una scelta faticosa, perché implica il superamento della rabbia. Ma la rabbia, alla lunga, è un fardello troppo pesante da portare. Una persona può impiegare anni a trovare la risposta giusta al dolore che le è stato inflitto. In fin dei conti il perdono non è tanto un regalo o una concessione che facciamo a un altro, quanto uno stato d’animo, un modo di sentire».
Come le è venuta l’idea di scavare nel suo passato per raccontare questa storia?
«Mio nonno, Victor Berger, fu affidato all’ Hebrew Orphan Asylum di New York in seguito all’abbandono della famiglia da parte del padre. Il personaggio dello stesso nome che compare nel romanzo è il mio modo di rendere omaggio alla sua memoria. Stavo svolgendo delle ricerche sugli orfanotrofi per bambini ebrei al fine di capire meglio la sua esperienza quando mi sono imbattuta nella storia degli 8 bambini e dei trattamenti a raggi x. In quel momento è nata l’idea del romanzo. Ho proseguito le mie ricerche negli archivi e nelle biblioteche della città e in seguito non ho esitato – con l’approvazione della mia famiglia – a inserire nella narrazione elementi ed episodi reali presi in prestito dall’esperienza dei miei antenati».
Cinzia Cinque
[Foto di Derek Feldman]